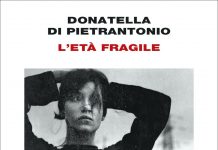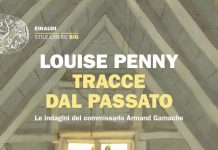Nell’aprile di quest’anno la pazienza degli aficionados dello Studio Ghibli è stata finalmente premiata con l’immissione sul mercato domestico de I miei vicini Yamada, opera della maturità di Isao Takahata costruita secondo una logica di sottrazione, di eliminazione del superfluo che privilegia la forma pura senza per questo rinunciare al dettaglio.
Primo film Ghibli a essere interamente realizzato con la colorazione digitale, I miei vicini Yamada riproduce lo stile narrativo delle strisce a fumetti di Hisaichi Ishii da cui è tratto, alimentando l’illusione che la macchina stia scorrendo dinanzi le pagine di un manga umoristico; di fatto, non possiamo parlare propriamente di trama dacché le sezioni che lo compongono sono a tutti gli effetti autonome e non seguono alcun criterio cronologico –fatto salvo forse il ciclo delle stagioni.
Ciascun capitolo, introdotto da un titolo e chiuso talvolta da un haiku, fornisce uno spaccato della vita degli Yamada, una famiglia giapponese media alle prese con problemi quotidiani quali l’educazione dei figli e i bisticci tra coniugi: tuttavia, raramente vedremo tutti i membri del nucleo in scena, poiché scopo dei siparietti è approfondire le alchimie tra i singoli componenti per poi regalare allo spettatore una esilarante prestazione collettiva. In alcuni di questi la fantasia la fa da padrona, come nell’episodio d’apertura con Takashi e Matsuko in cui il bob lanciato a grande velocità per i piani della torta e la nave in balìa delle onde –tra cui la celebre onda di Hokusai– sono allegorie del matrimonio; in seguito, le nuvole si diradano con l’arrivo dei figli. Alla tradizione occidentale della cicogna e del cavolo Takahata preferisce il folclore indigeno, sicché il primogenito Noboru, al pari di Momotaro, è trovato all’interno di una enorme pesca, mentre la piccola Nonoko in un fusto di bambù, come nel Taketori Monogatari.
A partire da quest’ultima osservazione, viene da chiedersi se già nel 1999 Takahata non avesse maturato il desiderio di trasporre cinematograficamente questa leggenda: i punti di contatto con La storia della principessa splendente, d’altronde, non mancano. Innanzitutto, i cromatismi e la tecnica ad acquerello impiegati ne I miei vicini Yamada sono i medesimi, nonostante il diverso supporto, e ricorre la stessa attitudine dei personaggi ad apprezzare le piccole cose, si tratti di un piacere frugale o di un elemento naturale.
In questo senso, l’episodio L’arte è concisa – La vita è lunga rappresenta una dichiarazione di poetica valida parimenti per il canto del cigno di Takahata: la scena si apre in primavera con Matsuko e l’anziana madre Shige che si imbattono in un ciliegio, al che la madre, malinconicamente, si chiede quante volte ancora potrà vederlo in fiore. Senza anticipare l’irresistibile motto con cui si chiuderà, possiamo dire che questa parentesi riflette pienamente la sensibilità della classe intellettuale del periodo Heian cui la leggenda della principessa Kaguya risale: i fiori di ciliegio che muovono Shige sono la sintesi del mono no aware –letteralmente, emozione delle cose– , poiché consentono la percezione della perfezione estetica e al contempo del destino di morte che incombe su tutto il creato, un destino che Kaguya, giovane bellissima ma solamente “in prestito” a questo mondo, comprende e accetta.
A ogni modo la pellicola non si prende mai troppo sul serio e ogni situazione, anche la più drammatica, si tramuta alfine in una gag improntata alla parodia e alla contaminazione tra generi sulle tracce del grande Osamu Tezuka, che ci ha insegnato come l’ironia non possa svilire il significato globale di un’opera fintantoché la sua intenzione comunicativa è chiara. Si considerino per esempio gli ultimi minuti dell’episodio Lotta per la giustizia, dove Shige affida a Takeshi il compito di far sgomberare una banda di motociclisti; con l’affacciarsi del pericolo, il registro cambia completamente, il tratto si fa più tagliente e si ha l’impressione di venire catapultati in una light novel per adulti.
Tuttavia, quando Shige attacca bottone con il capobanda, capisce che i centauri non sono bosozoku ma semplici teppistelli. Di lì a poco Takeshi, sentendosi esautorato della propria virilità, si immaginerà nei panni di Gekko Kamen, il paladino della giustizia degli anni Sessanta, e di sventare il rapimento della moglie. Ancora, pensiamo alla battaglia per il possesso del televisore in Matrimonio alla Yamada, con Matsuko e Takeshi che a colpi di telecomando e giornale scimmiottano le mosse dei chanbara.
Insomma, con I miei vicini Yamada Takahata ha voluto fare un passo indietro, ricuperare l’umorismo che era il tratto distintivo delle prime produzioni Ghibli e tornare alle origini dello studio, per non dire dell’animazione giapponese tout court. Con la loro “anormalità”, gli Yamada confutano il modello patriarcale ormai anacronistico dello ie e la sua rigidità nei ruoli di genere: Noboru è uno studente svogliato, Takeshi è severo solo in apparenza, Matsuko è una casalinga imbranata, la piccola Nonoko è fin troppo matura per la sua età, mentre Shige, seppur anziana, si comporta ancora come una bambina, ma nonostante nessuno assolva ai propri compiti in casa regna una –precaria– armonia garantita dal reciproco affetto. Il maestro sembra così volerci dire che la vita in famiglia è troppo imprevedibile per essere seri.