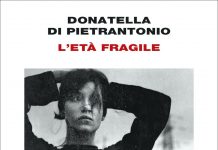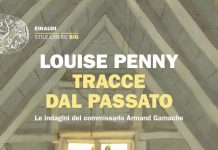Dopo quattro mesi di episodi uno più intenso e complesso dell’altro, Twin Peaks – The return giunge finalmente (?) a una conclusione con il consueto doppio episodio.
Il punto della situazione
Mentre Gordon rivela ad Albert un’informazione capitale su uno dei più grandi misteri della serie, BOB riesce finalmente ad arrivare nel luogo indicatogli dalle coordinate. Tutti i tasselli alla fine sono in posizione per la resa dei conti a Twin Peaks, in un modo o nell’altro, incluso Cooper, sulle cui spalle pesa l’onore di chiudere il racconto in un finale pienamente lynchano.
La serie
La puntata inizia dove si era chiusa la precedente, nella stanza dove si trovano Tammy, Albert e Gordon. Quest’ultimo si scusa per aver tenuto nascosta una sua conversazione precedente con Phillip Jeffries, il quale sosteneva di aver scoperto ai suoi tempi una “entità estremamente negativa”, chiamata Jowday, nome con il tempo naturalizzatosi in Judy, quel nome da cui in Fuoco cammina con me Bowie sembrava essere terrorizzato e di cui nemmeno BOB conosceva l’esatta essenza. Questo è l’indizio definitivo che ci fa capire come Lynch abbia rielaborato il Male all’interno della serie, facendola sì coincidere con la Madre/l’Esperimento, ma anche trascendendo quest’elemento; però questo lo vedremo dopo nel dettaglio.
 Ricevuta la tanto attesa telefonata da Cooper, quindi, anche il trio di cui sopra piomba al dipartimento assieme all’agente, i fratelli Mitchum e le conigliette solo per trovare il corpo di BOB a terra. Il doppelgänger è arrivato sul luogo a causa del Gigante, il quale è riuscito dove MIKE aveva fallito mettendo BOB nel sacco una volta per tutte con un piano studiato sulla lunga distanza, avendo predisposto sulla scacchiera tutti i pezzi necessari per assicurarsi di rispedirlo in pianta stabile nella Loggia Nera da cui mancava da 25 anni. Tant’è infatti che anche le altre coordinate erano sbagliate e lo hanno portato dritto dal Pompiere che assieme a Briggs lo ingabbia e lo riposiziona sul patibolo. Scopriamo che anche Billy, a questo punto corrispettivo di Cooper, come ipotizzato nella recensione della quindicesima parte, ma anche tulpa creato a partire da Chad (ripete i suoi insulti), in grado di creare la situazione necessaria per lo spostamento di Freddie dalla cella alla stanza dove BOB voleva resuscitare, era un’altra pedina nelle mani della guida della Loggia Bianca. BOB fallisce, probabilmente consapevole di giocarsi le ultime carte, nel fingersi Cooper nella stazione di polizia di Twin Peaks e infatti viene sparato da Lucy, che poco prima aveva condiviso una visione con Andy, istigata a scoppio ritardato dall’esperienza a cui il Gigante, ancora una volta, aveva dato vita nell’episodio XIV, creando i presupposti per uccidere prima il corpo fisico. I woodsmen intervengono curando con il sangue le ferite, ma BOB, ora non più “-in-Cooper” sa che non ha senso continuare a rimanere il quel corpo e attacca Freddie, che dopo uno scontro folle lo distrugge.
Ricevuta la tanto attesa telefonata da Cooper, quindi, anche il trio di cui sopra piomba al dipartimento assieme all’agente, i fratelli Mitchum e le conigliette solo per trovare il corpo di BOB a terra. Il doppelgänger è arrivato sul luogo a causa del Gigante, il quale è riuscito dove MIKE aveva fallito mettendo BOB nel sacco una volta per tutte con un piano studiato sulla lunga distanza, avendo predisposto sulla scacchiera tutti i pezzi necessari per assicurarsi di rispedirlo in pianta stabile nella Loggia Nera da cui mancava da 25 anni. Tant’è infatti che anche le altre coordinate erano sbagliate e lo hanno portato dritto dal Pompiere che assieme a Briggs lo ingabbia e lo riposiziona sul patibolo. Scopriamo che anche Billy, a questo punto corrispettivo di Cooper, come ipotizzato nella recensione della quindicesima parte, ma anche tulpa creato a partire da Chad (ripete i suoi insulti), in grado di creare la situazione necessaria per lo spostamento di Freddie dalla cella alla stanza dove BOB voleva resuscitare, era un’altra pedina nelle mani della guida della Loggia Bianca. BOB fallisce, probabilmente consapevole di giocarsi le ultime carte, nel fingersi Cooper nella stazione di polizia di Twin Peaks e infatti viene sparato da Lucy, che poco prima aveva condiviso una visione con Andy, istigata a scoppio ritardato dall’esperienza a cui il Gigante, ancora una volta, aveva dato vita nell’episodio XIV, creando i presupposti per uccidere prima il corpo fisico. I woodsmen intervengono curando con il sangue le ferite, ma BOB, ora non più “-in-Cooper” sa che non ha senso continuare a rimanere il quel corpo e attacca Freddie, che dopo uno scontro folle lo distrugge.
La chiave estetica utilizzata da Lynch per questa sequenza si manifesta nella sua chiarezza solo qualche minuto dopo, ma l’effetto è comunque mirabile. Con uno stile che rassomiglia alla trilogia de La casa di Raimi, Lynch segue un BOB sotto forma di sfera oscura levitante tentare di uccidere i presenti per scappare, mentre Freddie al grido di “questo è il mio destino” e a forza di ganci destri cerca di ucciderlo. Passando da una CGI volontariamente posticcia a riprese in prima persona rispetto al punto di vista del mostro, con gli stilemi degli anni ’80 questo scontro diventa un’ode a quanto è rimasto indietro con il revival, vale a dire quelle modalità orrorifiche plastiche che fanno dell’allontanamento dal naturalismo moderno il loro punto forte. Di un barocco meravigliosamente pieno di sé ancora più pacchiano delle scene volontariamente teatrali delle Logge, questo conflitto racchiude in sé una delle chiavi per concepire la fine di questi 18 episodi e anche di tutto l’universo twinpeaksiano. BOB muore in modo assurdo, rocambolesco senza perseguire un vero obiettivo perché in quanto emanazione del male puro insegue la propria riproduzione all’infinito e il godimento immediato, il suo scopo è sussistere, e, ancor di più, fare da contrappunto. Perché è nella natura stessa del conflitto come in-sé che sta il cuore pulsante di Twin Peaks, dagli anni ’90 sino a oggi, ma anche questo è un indizio che ci serve per spiegare il finale, e verrà chiarito successivamente.
 Dopo questo roboante showdown la faccia di Dale Cooper si sovrappone all’inquadratura mentre quello diegetico vuole mettere fine a tutta la vicenda. Si reicontra con Diane, come intuito nella scorsa puntata coincidente con Naido, spiegandosi e riconoscendosi nei vari ruoli giocati nel grande piano del Gigante e di MIKE; quest’ultimo inoltre, in uno dei momenti più sottili e fini di tutta la serie in generale dimostra un grado di consapevolezza altissimo. A questo punto è intuibile che davvero i due leader di Loggia fossero d’accordo fin dall’inizio: MIKE e la sua serie interminabile di tentativi per frodare il suo acerrimo arrivare erano solo una messinscena per permettere al Gigante di dargli la stoccata finale, agiva come se stesse realizzando una volontà personale mentre in realtà serviva l’Equilibrio, che a questo punto potremmo proclamare il Nastro (non confinato alle Logge, ma totalizzante) del Conflitto, agendo da specchietto per le allodole, che comunque siamo noi spettatori, ancora persi e nudi come Jerry Horne in attesa di essere recuperati da Ben, ultimo personaggio-allegoria ad apparire in quanto incarnazione della TV, arrogante, saccente e ignorante, al punto da sfiorare più di tutti il Gigante senza accorgersene.
Dopo questo roboante showdown la faccia di Dale Cooper si sovrappone all’inquadratura mentre quello diegetico vuole mettere fine a tutta la vicenda. Si reicontra con Diane, come intuito nella scorsa puntata coincidente con Naido, spiegandosi e riconoscendosi nei vari ruoli giocati nel grande piano del Gigante e di MIKE; quest’ultimo inoltre, in uno dei momenti più sottili e fini di tutta la serie in generale dimostra un grado di consapevolezza altissimo. A questo punto è intuibile che davvero i due leader di Loggia fossero d’accordo fin dall’inizio: MIKE e la sua serie interminabile di tentativi per frodare il suo acerrimo arrivare erano solo una messinscena per permettere al Gigante di dargli la stoccata finale, agiva come se stesse realizzando una volontà personale mentre in realtà serviva l’Equilibrio, che a questo punto potremmo proclamare il Nastro (non confinato alle Logge, ma totalizzante) del Conflitto, agendo da specchietto per le allodole, che comunque siamo noi spettatori, ancora persi e nudi come Jerry Horne in attesa di essere recuperati da Ben, ultimo personaggio-allegoria ad apparire in quanto incarnazione della TV, arrogante, saccente e ignorante, al punto da sfiorare più di tutti il Gigante senza accorgersene.
 Oppure possiamo fare come Cooper, calandoci anima e corpo nella narrazione di Twin Peaks, nella straordinaria meta-narratività (e non meta-narrazione)della seconda parte di questo doppio finale. Il succitato Cooper sovraimpresso emula Monica Bellucci ricordandoci che quello che viviamo è un sogno, mentre il Cooper che abbiamo imparato a conoscere sullo schermo si fa guidare da MIKE nel convenience store ove risiede Jeffries per la messa in atto del piano definitivo, ovvero riscrivere tutto, salvando Laura Palmer andando a ritroso nel tempo. Con un’altra rivelazione enorme la carampana che una volta assomigliava a David Bowie manda Cooper alla data della morte di Laura per salvarla, ma qualcosa va storto, la mano della ragazza si sfila dalla presa di quella dell’agente. Andando con ordine, il fumo che fuoriesce da Jeffries prende prima la forma del simbolo dei gufi, quello raffigurato sulle spille del fu Nano, per poi scomporsi geometricamente divenendo una sorta di “8” o piuttosto un simbolo dell’infinito, arricciato però sul modello nel nastro di Möbius. Nello scorrere del tempo che per Lynch è greco, cioè ciclico, in uno slancio di visione dell’arte incredibilmente potente, Jeffries trova il punto dove mandare Cooper. Dalla comparsa di MIKE in poi la sequenza è da brividi; questi con la filastrocca si lancia trai due mondi (con molto più potere di quanto non facesse sembrare) e nella stratificazione degli spazi dimensionali tutto acquisisce una tonalità sempre più tendente al b/n, fino a quando, nel 1989, l’estetica arriva a collimare con quella dell’ottavo episodio. A cavallo fra footage di Fuoco cammina con me e una CGI, per Laura, di una grazia incredibile (vedasi come il contrasto con la baroccaggine degli effetti speciali della sequenze di combattimento ne sottolineano la leggerezza), assistiamo alla scena che segna lo stacco tra prima e seconda parte, determinando anche la fine della narrazione diegetica, con la scomparsa definitiva di Laura, preparandoci all’ultimo atto. Rimane comunque tutto inutile, perché la pesca del vecchio Pete può andare bene senza incappare nel suo cadavere, e allo stesso modo Sarah Palmer/Jowday può scagliarsi contro l’immagine di sua figlia in un tripudio di inquietudine per averne parso la garmonbozia, ma questo non inficia nemmeno lontanamente il Nastro. Tutto è insignificante.
Oppure possiamo fare come Cooper, calandoci anima e corpo nella narrazione di Twin Peaks, nella straordinaria meta-narratività (e non meta-narrazione)della seconda parte di questo doppio finale. Il succitato Cooper sovraimpresso emula Monica Bellucci ricordandoci che quello che viviamo è un sogno, mentre il Cooper che abbiamo imparato a conoscere sullo schermo si fa guidare da MIKE nel convenience store ove risiede Jeffries per la messa in atto del piano definitivo, ovvero riscrivere tutto, salvando Laura Palmer andando a ritroso nel tempo. Con un’altra rivelazione enorme la carampana che una volta assomigliava a David Bowie manda Cooper alla data della morte di Laura per salvarla, ma qualcosa va storto, la mano della ragazza si sfila dalla presa di quella dell’agente. Andando con ordine, il fumo che fuoriesce da Jeffries prende prima la forma del simbolo dei gufi, quello raffigurato sulle spille del fu Nano, per poi scomporsi geometricamente divenendo una sorta di “8” o piuttosto un simbolo dell’infinito, arricciato però sul modello nel nastro di Möbius. Nello scorrere del tempo che per Lynch è greco, cioè ciclico, in uno slancio di visione dell’arte incredibilmente potente, Jeffries trova il punto dove mandare Cooper. Dalla comparsa di MIKE in poi la sequenza è da brividi; questi con la filastrocca si lancia trai due mondi (con molto più potere di quanto non facesse sembrare) e nella stratificazione degli spazi dimensionali tutto acquisisce una tonalità sempre più tendente al b/n, fino a quando, nel 1989, l’estetica arriva a collimare con quella dell’ottavo episodio. A cavallo fra footage di Fuoco cammina con me e una CGI, per Laura, di una grazia incredibile (vedasi come il contrasto con la baroccaggine degli effetti speciali della sequenze di combattimento ne sottolineano la leggerezza), assistiamo alla scena che segna lo stacco tra prima e seconda parte, determinando anche la fine della narrazione diegetica, con la scomparsa definitiva di Laura, preparandoci all’ultimo atto. Rimane comunque tutto inutile, perché la pesca del vecchio Pete può andare bene senza incappare nel suo cadavere, e allo stesso modo Sarah Palmer/Jowday può scagliarsi contro l’immagine di sua figlia in un tripudio di inquietudine per averne parso la garmonbozia, ma questo non inficia nemmeno lontanamente il Nastro. Tutto è insignificante.
Il breve intervallo tra i due scaglioni è colmato dall’ultima scena musicale al Roadhouse, che ribadisce la dimensione del sogno e ci ricorda che le dimensioni si fondono. La seconda parte non segue affatto il crescendo precedente ma si configura più come una conclusione riflessiva, quello di cui Twin Peaks aveva bisogno, con cinquanta minuti che essenzialmente parlano di consapevolezza e arte allo stato puro, senza però scivolare minimamente nello spiegone o nel banale aftermath. Il colpo di scena c’è, però, sottile, nascosto, ma epocale. Ripercorrendo per un breve tratto il primo episodio della terza stagione, Lynch non ci delude, e come si era già notato proprio nella coppia di puntate inziali, fa della temporalità uno dei temi portanti del finale, rivelandoci che quanto abbiamo visto nella fuga di Cooper del terzo episodio era in realtà la fine, ovvero sia il tentativo disperato, quando era già nella Loggia Bianca, di salvare Laura dopo il primo fallimento del viaggio temporale.
 Tant’è che incontra Naido, ancora con il suo aspetto sigillato, in quella dimensione, e Phillip Jeffries (senza fumo, però). Jeffries, ora è chiaro, è come Lynch, che cerca di guidare il sognatore, noi, ovvero Cooper, ovvero noi, in un viaggio che con la sua conclusione ci pone davanti alla stessa natura di Twin Peaks. Dobbiamo accettare che è tutto ciclico, tutto irrilevante. Cooper segue le indicazioni del Gigante per entrare in un altro piano temporale, e qui ha una focosa notte d’amore con Diane. Il mattino seguente lui è Richard e lei è Linda: lei ha capito, lui (noi) no. Cooper cerca Laura Palmer, che però adesso si chiama Carrie Page, e vuole riportarla da sua madre, la cui casa è però quella di Alice Tremond (alter-ego della padrona di casa Mrs. Chalfont). Immagine commovente quella il regista dà di se stesso, quella non del maestro, ma dello spettatore consapevole.
Tant’è che incontra Naido, ancora con il suo aspetto sigillato, in quella dimensione, e Phillip Jeffries (senza fumo, però). Jeffries, ora è chiaro, è come Lynch, che cerca di guidare il sognatore, noi, ovvero Cooper, ovvero noi, in un viaggio che con la sua conclusione ci pone davanti alla stessa natura di Twin Peaks. Dobbiamo accettare che è tutto ciclico, tutto irrilevante. Cooper segue le indicazioni del Gigante per entrare in un altro piano temporale, e qui ha una focosa notte d’amore con Diane. Il mattino seguente lui è Richard e lei è Linda: lei ha capito, lui (noi) no. Cooper cerca Laura Palmer, che però adesso si chiama Carrie Page, e vuole riportarla da sua madre, la cui casa è però quella di Alice Tremond (alter-ego della padrona di casa Mrs. Chalfont). Immagine commovente quella il regista dà di se stesso, quella non del maestro, ma dello spettatore consapevole.
Ecco perché Bob trova la sua fine in modalità così grame, ecco perché Judy’s è il bar dove si scatena un altro inutile conflitto. Judy, cioè l’Esperimento è il Male perché in essa giace il conflitto-in-sé. In pieno stile John Ford la nuova avventura di Cooper inizia salvando una bella da dei molestatori, come in un racconto folkloristico, alla tavola calda Judy’s. Twin Peaks è solo una sfaccettatura, e noi spettatori non viviamo il sogno immaginifico di una storia (sarebbe troppo naïf), ma l’intero corso degli avvenimenti di tutto ciò che ne sta fuori: è una serie sulla trascendenza, dove tutto si capovolge continuamente come su un nastro di Möbius, appunto, dalle infinite torsio, anche se poi la torsione è unica, e ognuno dei personaggi prende il ruolo di un altro al prossimo giro (in questo senso può ricordare Strade perdute, volendo). Il colpo di genio di Lynch sta nel fare di questo ciclo contorto una girandola di ogni eventualità, dal Twin Peaks dell’ABC e quello di Showtime a quello che aveva sognato di fare, in un gioco promiscuo e vitale dove tutte i cicli hanno sì una loro autonomia ma si mescolano gli uni con gli altri. La potenza nasce dalla ripetizione dell’uguale, cio+ dall’essere capaci di accettare che la storia che abbiamo visto sia del tutto insignificante, nell’universo totale della serie stessa, nel senso che né un Cooper né una Laura Palmer hanno una loro integrità ontologica ma sono solo la stessa riproposizione di un personaggio che prima aveva un altro nome e dopo ne avrà un altro ancora? Il Dougie-bis manufatto da MIKE per compiacere la famiglia rimastane privata non vale nulla di meno rispetto al Dale Cooper caffeina-dipendente programmatico che abbiamo amato seguire per quasi cinquanta episodi, così come le scene che riguardavano Audrey non sono affatto finalizzate a una ipotetica narrazione principale (che sarebbe questa) ma hanno lo stesso peso della stessa, solo si trovano in una diversione linea narrativa/torsione.
Quando Laura urla nel finale Cooper capisce che il ciclo non può subire alcun tipo di variazione, è tutto già scritto e ogni tentativo è inutile: per la prima volta vediamo che gli alberi-traliccio nella Loggia Nera sono tanti, almeno quanti i bollitori in quella Bianca. Loro sono coloro che hanno raggiunto la piena consapevolezza – altri spettatori, sì, come Lynch, ossia lo spettatore definitivo, l’artista – e ne hanno concepito la pienezza vitalistica, come Jeffries, che quando era ancora in vita non voleva parlare di Judy, che a questo punto non è nient’altro che il nome che viene dato al Nastro, o meglio, una torsione diegetica dello stesso, perché non voleva ammettere la verità. Adesso ce l’ha fatta, e come un meta-psicopompo ha il compito di aiutare i vari Cooper, gli spettatori che stanno guardando il finale in quel momento preciso, ad accettare al verità terribile dell’eterno conflitto auto-sussistente. Senza non esisterebbe nulla, perché esisterebbe una solo dimensione, mentre l’elettricità, che è conduttore di ambo le Logge, è l’emblema stesso dell’uomo artifex, che agisce nell’ordine si perseguire uno scopo. Questo è l’orizzonte lynchano estremamente crepuscolare dell’Occidente.
 Un finale agghiacciante, durissimo, dunque, che schiude l’intimità del pensiero lynchano in una sfera di altissimo livello narrativo e tecnico. Non siamo di fronte a un mero gioco estetico, liquidare Twin Peaks (o Lynch in generale) a un’esperienza visiva senza necessità di spiegazioni od ordinamenti è solo che insensato, c’è bisogno di una logica, ma l’unico approccio più stupido di questo è quello tecnicistico di tentare di smontare ogni singola inquadratura neanche fosse una sorta di cubo di Rubik metafisico, come se si trattasse di una sfida intellettiva; e infatti Twin Peaks è un’opera che analizzata e compresa ma senza un senso di cinema, di esperienza artistica e contemplazione critica nella sua totalità, non può penetrare a fondo. Il concetto espresso da Lynch con questo terribile e sublime finale è di un’intelligenza artistica mirabile, andando a scomodare la causa di ogni movimento del modo di pensare il “meta-“. Ci troviamo di fronte all’opera televisiva più innovativa e da cinema dell’ultimo mezzo secolo, quando cioè ancora Twin Peaks era quel fulmine a ciel sereno che cambiava un mezzo. Un capolavoro che si doppia. Il finale non è aperto, non apre i cerchi che la prima parte dello stesso aveva chiuso, ma li rinsalda nella loro immutabilità: Twin Peaks è finito, basta film o stagioni, così si chiude un’opera autoriale che ha tutti i crismi per andare a inserirsi nella già straordinaria filmografia di David Lynch come un prodotto cinematografico a tutti gli effetti. Sta a noi concepire la pienezza della notte finale, quella d’amore tra Cooper e Diane, godendo della conclusione, pronti con forza ricominciare il ciclo. Totale. Definitivo.
Un finale agghiacciante, durissimo, dunque, che schiude l’intimità del pensiero lynchano in una sfera di altissimo livello narrativo e tecnico. Non siamo di fronte a un mero gioco estetico, liquidare Twin Peaks (o Lynch in generale) a un’esperienza visiva senza necessità di spiegazioni od ordinamenti è solo che insensato, c’è bisogno di una logica, ma l’unico approccio più stupido di questo è quello tecnicistico di tentare di smontare ogni singola inquadratura neanche fosse una sorta di cubo di Rubik metafisico, come se si trattasse di una sfida intellettiva; e infatti Twin Peaks è un’opera che analizzata e compresa ma senza un senso di cinema, di esperienza artistica e contemplazione critica nella sua totalità, non può penetrare a fondo. Il concetto espresso da Lynch con questo terribile e sublime finale è di un’intelligenza artistica mirabile, andando a scomodare la causa di ogni movimento del modo di pensare il “meta-“. Ci troviamo di fronte all’opera televisiva più innovativa e da cinema dell’ultimo mezzo secolo, quando cioè ancora Twin Peaks era quel fulmine a ciel sereno che cambiava un mezzo. Un capolavoro che si doppia. Il finale non è aperto, non apre i cerchi che la prima parte dello stesso aveva chiuso, ma li rinsalda nella loro immutabilità: Twin Peaks è finito, basta film o stagioni, così si chiude un’opera autoriale che ha tutti i crismi per andare a inserirsi nella già straordinaria filmografia di David Lynch come un prodotto cinematografico a tutti gli effetti. Sta a noi concepire la pienezza della notte finale, quella d’amore tra Cooper e Diane, godendo della conclusione, pronti con forza ricominciare il ciclo. Totale. Definitivo.