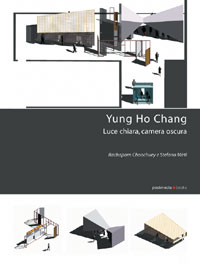Nei due aforismi citati c’è tutto il significato di un libro sull’architettura cinese post-comunista: da un lato il gioco neodadaista, dall’altro la spiritualità tipica di un architetto orientale, ma forse sarebbe più giusto definirlo un artista d’opere architettoniche.
“All’artista, ci credo. All’opera no.”
Marcel Duchamp
“Il desiderio di vincere, il desiderio di arrivare a degli obiettivi, la necessità di sfruttare completamente il proprio potenziale assoluto… Queste sono le chiavi che apriranno la porta dell’eccellenza personale.”
Confucio.
Il testo intitolato metaforicamente Yung Ho Chang – Luce chiara, camera oscura, a cura di Rachaporn Choochuey e Stefano Mirti, è diviso in due sezioni: la prima composta di tre interviste e la seconda da alcuni capitoli che affrontano sia la grammatica del linguaggio progettuale di Yung Ho Chang – interpretando i materiali che usa solitamente – sia la documentazione dei suoi progetti, basandosi solo su installazioni per mostre. Una metodologia per scoprire come l’architetto/artista concepisce, progetta e edifica le sue opere.
Si potrebbe commentare che il testo tratta essenzialmente del Tao dell’architettura, nella quale passato e presente s’intersecano, legandosi a loro volta con il futuro. Tao che significa “La Via” o “Il Sentiero” – spesso anche tradotto “Il Principio” – è uno dei concetti essenziali della filosofia cinese. È l’eterna, rigorosa e fondamentale energia che circola in tutta la materia dell’Universo. Per dirla con un solo termine, il Tao «E’». Da qui derivano lo “Yang” il principio positivo maschile, rappresentato col bianco e lo “Yin” il principio negativo femminile, rappresentato col nero.
Per meglio intendersi si legga l’inizio del capitolo Dodici progetti di Yongh Ho Chang e Atelier Feichang Janhzu. 01. Trace of Existence. Pechino 1998: “Una porta per entrare nella luce, una porta per entrare nel buio. In Occidente esiste una dicotomia tra quelli che fanno e quelli che pensano: riguardo alle interviste e i commenti di Yung Ho Chang, forse questo fenomeno capita anche in Cina. Ma, a prescindere dalle latitudini e longitudini, il suo universo è quello dove per capire le cose c’è un grandissimo investimento in termini di ‘fare’. Tuttavia non è il ‘fare’ dell’artigiano, è un fare profondamente intellettualizzato, come fosse un cruciverba o un rebus in termini di congegno spaziale […] Leonardo ci dà una possibile indicazione: “Dove lo spirito non lavora con la mano, non c’è arte” […].”
Ad un certo punto i curatori gli chiedono di ricordare le sue esperienze universitarie in Cina e in America. Yung Ho Chang allora parla, fra l’altro, di Lars Lerup suo ex docente: “Nel 2002 sono tornato a Berkeley come insegnante. Ho lavorato a stretto contatto con lui per due anni. Un giorno, dopo pranzo, sotto l’intensa luce californiana stavamo parlando e lui dice una frase che non riesco a comprendere immediatamente. In quel periodo facevo cose che erano più vicine all’arte che all’architettura: progettazione per concetti, lavori teorici, installazioni. Mi disse “Tu stai lavorando in una camera oscura, dovresti realmente cercare di uscire fuori”. Non era affatto facile comprendere questo concetto della camera oscura […] In seguito l’ho capito molto bene […] voleva suggerire che bisogna affrontare la sfida della professione, non limitarsi al coinvolgimento in attività teoriche.”
Sempre discutendo delle sue esperienze architettoniche, gli interlocutori gli domandano: “Abbiamo anche letto Planned Assault, il libro di Lars Lerup nel quale si trovano i progetti per la “Nofamily House”, la “Love/House” e la “Texas Zero House”. Peter Eisenman ha scritto che se le case di Le Corbusier erano pensate come macchine per abitare, quelle di Lerup sono ‘macchine per sognare’. Trappole dadaiste, piazzamenti, cambi improvvisi sono tutti parte dei suoi strumenti progettuali, mentre le sue fonti di ispirazione vanno cercate nella poesia, nella filosofia, nella psicoanalisi […] C’è questa frase scritta su una casa di Lerup: “Le sue creazioni invitano l’abitante o il visitatore momentaneo a lasciarsi dietro gli schemi della sua vita quotidiana, per entrare per entrare nell’immaginifico mondo dell’architettura”. Potremmo applicare una frase come questa anche nei tuoi lavori?” L’artista/architetto risponde: “Sarebbe bello. Questo è l’aspetto magico dell’architettura.” Nella replica di Yung Ho Chang c’è tutto il suo ammaliante universo progettuale, che non si limita solo ad elaborare abitazioni, centri urbani e musei – come fanno gli altri suoi colleghi -, ma concepisce l’architettura, il design – nel libro accenna ad un suo progetto di rielaborazione, soprattutto grafica, di un’automobile per conto della Volkswagen – e l’urbanistica a livello filosofico e in parte ludico. Non però come un gioco, bensì alla maniera di Marcel Duchamp: un artifizio per penetrare più a fondo nell’animo dell’uomo e allo stesso tempo per fargli comprendere che non basta abitare, vivere in un qualsiasi ambiente, ma bisogna guardare, osservare, percepire la sua essenza. La stessa che fa, o per lo meno dovrebbe far sognare chi vi abita, vive, lavora, gioca, studia. Insomma: l’atipica architettura di Yung Ho Chang, che fra gli architetti cinesi dell’ultima generazione è indubbiamente uno di quelli sotto più “stretta osservazione”, basti ricordare la progettazione di una città-museo e che fra il materiale abitualmente usato, in particolare per le sue “installazioni”, ci sono il bambù, la carta di riso, scatole e ruote di biciclette – con queste ultime ha ideato mensole per libri -, tutti prodotti tipici cinesi che, pur adoperati tecnicamente, appartengono prima di tutto alla tradizione orientale.
Dei dodici progetti di Yung Ho Chang che i curatori descrivono, il più interessante senza dubbio è Trace of Existence: una “installazione” formata da un portone metallico che scorre e che si piega. Un prodotto composto di pochi, ma essenziali elementi, solo un po’ di lavoro di falegnameria e si è così ottenuta un’opera d’arte concettuale: disadorna, essenziale, “aperta”.
Nato nel 1956 a Pechino, ha vissuto per quindici anni negli States prima come studente e in seguito da docente. Nel 1993 sceglie di ritornare nel suo Paese. Con la moglie Lijia Lu fonda il primo studio privato su suolo cinese, battezzandolo “Atelier Feichang Jianzhu”. Tradotto in italiano potrebbe significare “architettura insolita” oppure “costruzione irregolare”. Irregolare, ma per quale motivo? L’architetto cino/americano si nutre di un presente che si basa su una profonda cognizione del passato. Con la stessa metodologia Yung Ho Chang realizza la “Split House” (2002), nella quale fa uso di accostamenti fra materiali vecchi e odierni: “Ho usato legno e cemento in modo da fondersi appunto con il paesaggio, così che quando uno vi si avvicina non ha la sensazione che la casa sia nuova ma faccia parte già da tempo della collina, sulla quale non sono intervenuto. Questo è molto orientale”. Affermando la propria filosofia di concepire l’architettura quale forma del tempo, ci sia consentito di poter parafrasare il libro di Gorge Kubler La forma del tempo.
Yung Ho Chang è un vero architetto contemporaneo poiché riesce a combinare elementi diversi e anche a essere provvisto di una sensibilità composita e di una concezione complessiva del proprio lavoro. Basti assaporare l’intervista di Hans Ulrich Obrist contenuta nel testo: “Per me la globalizzazione è un fenomeno molto interessante, questo non perché qui l’economia sia in pieno boom o perché la Cina stia diventando un soggetto più importante nelle dinamiche globali. Piuttosto, dal punto di vista professionale, quello che mi interessa è quale tipo di scambio culturale sia ingenerato dalla globalizzazione”. Yung Ho Chang però è anche molto interessato ad interagire con la contemporaneità, grazie ai suoi poliedrici interessi, non da ultimo il campo dell’arte. Nella prima intervista di Rachaporn Choochuey e Stefano Mirti, riferisce della sua immensa passione per la pittura e ammette che solo la propria incapacità tecnica lo ha portato a mutare corso ai propri interessi. Difatti i nomi di artisti del calibro di Duchamp, John Cage e James Turrell sono citati negli scambi di idee con i suoi intervistatori. Non solo, Yung Ho Chang ha progettato lo “SMOCA-Small Museum of Contemporary Art” per l’artista e amico Cai Guo-Qiang. Dopo l’incontro con Hou Hanru e Hans Ulrich Obrist ha contribuito a progettare l’installazione di una mostra importante come Cities on the Move (1997- 1999). Alla “Biennale” di Venezia del 2003 si è potuta osservare una sua struttura di bambù che è servita come sede del padiglione cinese.
Luce chiara, camera oscura si concentra particolarmente su questo tipo di attività dell’architetto, sulle proprie riflessioni e sulla metodologia con cui si interpreta quotidianamente assieme ai propri collaboratori – spesso colleghi già affermati, ma anche giovani e promettenti allievi – non solo nelle realizzazioni concrete, ma in particolare per mezzo di mostre e “installazioni”.
A chi è rivolto il saggio? Agli studenti e ai giovani architetti, anche se di tutte le opere di Yung Ho Chang sono prese in esame solo le “installazioni” e le architetture temporanee. Soprattutto è un testo per persone curiose – non è obbligatorio essere degli specialisti del campo -, poiché racconta della formazione di un intellettuale nella Cina di Deng Xiao Ping e negli USA di Reagan, parla di alcuni suoi maestri, facendo dei rimandi alla cultura tradizionale cinese e alla propria neo-politica, soprattutto commerciale. Un libro d’architettura dove non si discorre solo di architettura: il suo orizzonte è assai più ampio. Un testo in cui la parola scritta ha più peso delle sue pur eleganti e significative immagini.
Se poi i lettori di questa recensione risultassero interessati a Yung Ho Chang, c’è un altro bel volume che lo riguarda, scritto da Laurent Gutierrez e Valerie Portefaix, due francesi che vivono ad Hong Kong: Yung Ho Chang: Atelier Feichang Jianzhu – A Chinese Practice, “Map Books Publisher”, Hong Kong.
“Yung Ho Chang. Luce chiara, camera oscura”
A cura di Rachaporn Choochuey e Stefano Mirti
“postmedia books”
Collana: Architettura
Prezzo euro 16.00 €